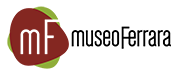Eugenio Ravenna (1920-1977)

Eugenio Ravenna, detto Gegio, è uno dei cinque ebrei ferraresi sopravvissuti al campo di sterminio di Auschwitz.
2. La Comunità dei sopravvissuti
A meno di due settimane dal ritorno a Ferrara, Eugenio Ravenna riceve, il 26 settembre, una lettera da Aldo Moscati, che gli chiede se ha notizie di suo fratello Giorgio. Il 6 ottobre gli scrive Luciana Nissim che saluta con felicità il suo ritorno, gli racconta degli altri scampati all’orrore dei lager (tra cui lei stessa e Primo Levi) e gli comunica con dolore della morte della madre di Eugenio Ravenna, Letizia Rossi, di sua sorella Franca Ravenna, di sua zia Milena e di altre cugine, tutte con lei nella sezione femminile del campo di Auschwitz. Inoltre, gli chiede di restare in contatto. È l’inizio di una corrispondenza epistolare tra i sopravvissuti che si allarga a comprendere, tra gli altri, Silvio Barabas, Leonardo De Benedetti e Primo Levi, che scrive a Eugenio Ravenna il 6 dicembre 1945: “Comprendo assai bene la terribile sensazione di vuoto che ti circonda: solo adesso ci rendiamo esattamente conto di quanto abbiamo perduto”. Eugenio Ravenna scrive a Leonardo De Benedetti del suo dolore atroce “finché la mattina del 9 maggio, mentre stavo dando il primo colpo di vanga alla mia trincea a 7 km dagli alloggi, arriva la notizia della vittoria” (1). Il carteggio continua anche negli anni successivi, quando la vita torna a scorrere a Ferrara, sulle cicatrici dei campi di sterminio. Tutte le lettere, 35 in tutto, sono state conservate prima da Nara Forti, vedova di Eugenio Ravenna (morto nel 1977), poi da Paolo Ravenna, custode di memorie ebraiche ferraresi.
1. Dati biografici
Eugenio Ravenna, detto Gegio, nasce a Ferrara il 16 novembre 1920. È figlio di Gino Ravenna, proprietario di un deposito alimentare e di Letizia Rossi, nonché cugino dello scrittore Giorgio Bassani e dell’avvocato Paolo Ravenna. Ebreo di estrazione borghese, Eugenio Ravenna, che aveva frequentato il liceo scientifico fino alla soglia della maturità e avendo dovuto poi interrompere gli studi per le leggi razziali, viene arrestato l’8 ottobre 1943, mentre i suoi familiari vengono fermati nel dicembre dello stesso anno, dopo aver cercato rifugio in Svizzera. Eugenio Ravenna è condotto prima al carcere di Bologna, poi in quello di Ferrara e da lì al complesso di via Mazzini 95. Trasferito al campo di concentramento di Fossoli (Modena), è poi deportato con la sua famiglia nel campo di sterminio di Auschwitz sul convoglio n. 8, che parte il 22 febbraio 1944 per arrivare quattro giorni dopo. Liberato il 27 gennaio 1945, è il solo della sua famiglia a sopravvivere alla Shoah; il padre Gino Ravenna, la madre Letizia Rossi, la sorella Franca Ravenna, il fratellino quindicenne Marcello Ravenna ed altri quattro zii e cugini scompaiono nel lager nazista. Eugenio Ravenna torna a Ferrara il 15 settembre 1945; rimasto solo, la sua storia ispira “Una lapide in via Mazzini” di Giorgio Bassani, dove Eugenio Ravenna, nel racconto diventato Geo Josz, unico sopravvissuto a Buchenwald dei 183 ferraresi deportati, ritorna in una Ferrara che ha inserito anche il suo nome tra quelli sulla lapide commemorativa in via Mazzini e che lo riceve con soggezione, ansiosa solo di dimenticare.
3. Testimonianze
Testimonianze di Eugenio Ravenna
“Fui arrestato l’8 ottobre qui nella mia casa, nella mia camera da letto, dalla questura italiana e dalle Brigate nere insieme, quindi fui trasportato a Bologna a San Giovanni in Monte insieme con altri politici e israeliti di Ferrara. Dopo una settimana fummo riaccompagnati a Ferrara con la promessa di essere liberi, perché ancora le disposizioni feroci di antisemitismo non erano state emesse dal governo di Salò. La mia famiglia era sfollata in campagna […] Lì combinarono […] di poter andare in Svizzera; […] passarono la frontiera, furono accolti dalle guardie svizzere, ma rimandati indietro. […] si rifugiarono a Domodossola in un albergo, […] dopo poche ore, capitò la polizia italiana e li arrestò. Io li credevo in salvo, ma li vidi capitare a Ferrara nel mio carcere […]. Lì siamo rimasti fino ai primi di febbraio, poi, una mattina, fummo avviati al nostro tempio, alla sinagoga. […] La mattina dopo, la polizia italiana ci fece caricare sui pullman e trasportare a Fossoli. Fossoli durò poco, non si stava male, c’era una certa libertà. […] Poi un giorno ci portarono a Carpi e ci caricarono sui carri-bestiame. Giorni e giorni d’inverno in un vagone, caricati uno sopra l’altro, con la paglia sporca dopo poche ore, sporca di tutti i bisogni […]; giorni e giorni senza mangiare […] Insomma fu terribile”. (Eugenio Ravenna, La forma del cranio, in Il coro della guerra, pp. 83-84).
“Dovevamo andare a Auschwitz. L’avevamo letto nel cartellino di destinazione del vagone in quei pochi attimi d’aria. Auschwitz, per noi non diceva ancora niente, ma i tedeschi, gli jugoslavi […] legati al nostro stesso destino, sapevano di che cosa erano capaci i tedeschi. […] Auschwitz ci si spalancò davanti al vagone nel buio, verso le otto di sera. […] Le SS si mettevano da spartitraffico: uomini da una parte, donne dall’altra; uomini validi da una parte, uomini non validi dall’altra; così per le donne e i bambini. E lì fui separato da mia mamma e da mia sorella. […] Rimasi con mio fratello, il mio fratellino di tredici anni, che mi era dietro. Ci buttarono su un camion. Riuscii a vedere ancora mia mamma e mia sorella in un altro camion, chiamai, ma non c’era modo di farsi sentire. Nel camion mi ritrovai con mio padre, ma il fratellino non c’era più. Da quel momento abbiamo capito che per gli altri non c’era più speranza. […]. Ci portarono nel campo di Monowitz – un sotto-campo di Auschwitz – e ci fecero stare lì una notte intera nudi completamente, in una camera […] Sentimmo una campana che ordinava la sveglia, […] ci obbligarono alla disinfestazione […], poi ci fecero andare tutti nudi fuori attraverso la neve in un’altra baracca; lì ricevemmo le famose casacche a righe, i calzoni, una specie di cappotto e ci avviarono con questi zoccoli di legno che a volte erano scompagnati […]”. (Eugenio Ravenna, La forma del cranio, in Il coro della guerra, pp. 84-86).
“Arrivammo in una baracca e lì ci impressero il numero sull’avambraccio sinistro. Io ho ancora il numero 174542, mio padre aveva il 174541. Alla sera verso le cinque e mezzo ci portarono nella grande piazza dell’appello, per primi. Si dovette aspettare tutti gli altri, circa diecimila deportati, che rientrassero dal lavoro. Uno proprio non sa cosa dire, come cascare in un altro mondo […] vedere queste diecimila persone tutte in fila per cinque, comandate, andavano al passo. E il loro colore! Era una massa grigiastra […] uniforme, era un grigio che quasi dava all’azzurrognolo. Il cranio che s’intravedeva dal baschetto appariva proprio come la struttura ossea della testa. […] Sono stato in Germania dopo la guerra. ‘Noi non sapevamo niente’, dicevano i tedeschi. Come, non sapevate niente! Dove lavoravo io, nei dintorni di Auschwitz, c’erano centinaia di tedeschi che lavoravano, tecnici, ingegneri, chimici […] Alla fine della settimana tornavano nelle loro città. Lo dicevano? Lo raccontavano? […]” (Eugenio Ravenna, La forma del cranio, in Il coro della guerra, pp. 86-87).
“Mio padre, un uomo di cinquant’anni, non ha resistito più di un mese e mezzo. Il lavoro era pesantissimo, un suo potenziale disturbo si riacutizzò. […] capirono che era un elemento irrecuperabile e quindi alla prima occasione lo fecero ‘trasferire’. Non era un trasferimento, era l’eliminazione. Avveniva sempre di domenica, per non perdere le ore di lavoro. […] Montavano su un camion, dopo poche ore ritornavano i vestiti. […] Era la lotta per sopravvivere. Io, mi sono lasciato trasportare dalla corrente, non ho mai avuto grandi aiuti, non lo so, ho rischiato […] di finire eliminato. Non so come mi è andata bene”. (Eugenio Ravenna, La forma del cranio, in Il coro della guerra, pp. 87-88).
Note
(1) Francesco Erbani, “La Repubblica”, 24 gennaio 2008
Bibliografia
Sitografia
- http://dati.cdec.it/lod/shoah/persecution/6650
- http://digital-library.cdec.it/cdec-web/persone/detail/person-6650/ravenna-eugenio-1.html
- http://www.nomidellashoah.it/1scheda.asp?nome=Eugenio&cognome=Ravenna&id=6650
- http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2008/01/24/la-comunita-dei-sopravvissuti.html
Eventi correlati
Soggetti correlati
Luoghi correlati
Ente Responsabile
- Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara
Autore
- Edoardo Moretti